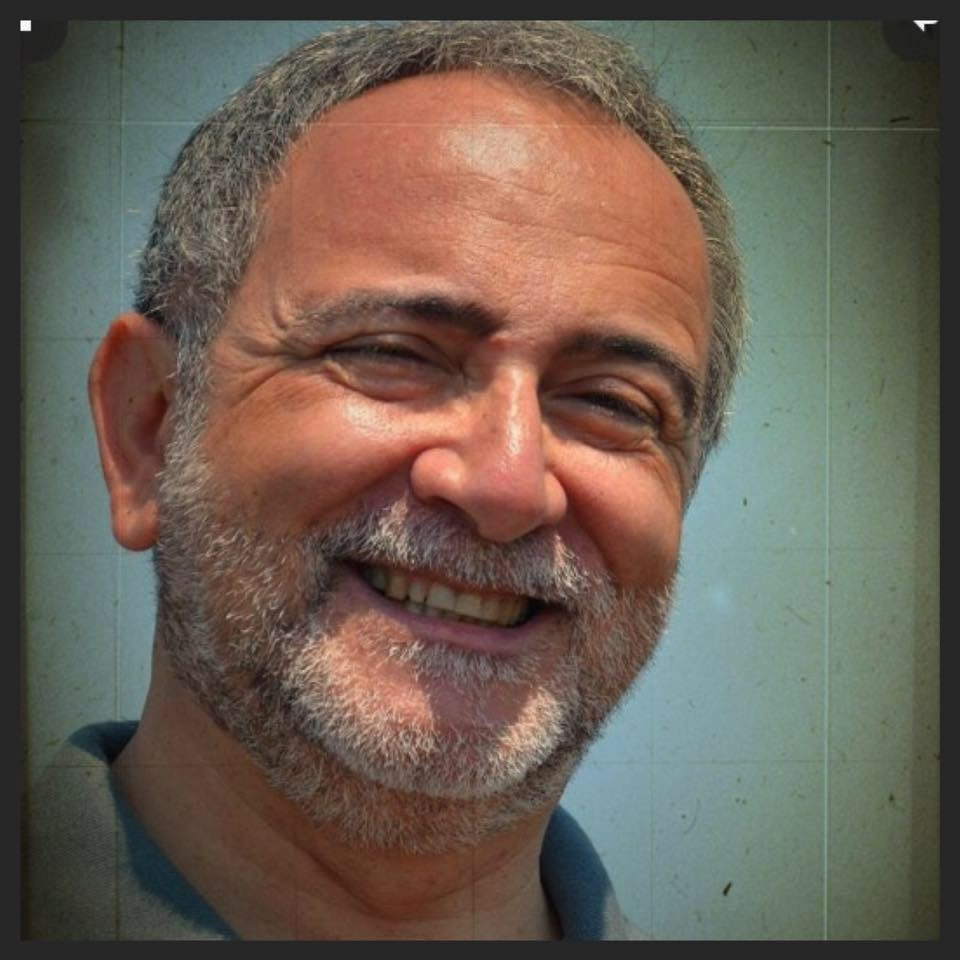LA TERAPIA DI GRUPPO
Come una orchestra, ognuno ha il suo spartito, lo strumento di uno esprime e varia quello dell’altro
TERAPIA DI GRUPPO
Come una orchestra, ognuno ha il suo spartito, lo strumento di uno esprime e varia quello dell’altro.
Qual è la definizione di gruppo? Insieme di cose o persone, distinte l’una dall’altra, ma riunite insieme in modo da formare un tutto: un gruppo di case, un gruppo di persone, un gruppo di stelle.
In maniera più cinica potremmo dire che un gruppo è un’aggregazione di persone che rispondono a un controllo unico, ma questa definizione, la lascerei volentieri a chi si occupa di holding o al massimo a chi si sente un orwelliano convinto, convinto che quel romanzo, 1984, presenta un inesorabile cosmo a cui tutti, volenti o nolenti, siamo assoggettati.
Quello che incuriosisce di più della parola “gruppo” è in realtà la parola che segue o quella che precede, perché fa spremere meno le meningi: gruppo sanguigno, gruppo rock, gruppo sociale, gruppo d’artiglieria … Terapia di gruppo. Terapia di gruppo, già!
Mi fa pensare, e sapete perché? Perché nella frase “terapia di gruppo” manca l’aggettivo. E’ possibile che l’assenza di un aggettivo faccia pensare? Direi di più. Porta all’insonnia.
Verrebbe da ridere. Basta non ignorare l’idea che un aggettivo dà coordinate precise alla nostra mente, e che senza di esse ci sentiamo persi. Il concetto di scatola è torbido se rapportato a quello di scatola rosa. E cos’è una terapia di gruppo? Per me erano due sostantivi uniti da una preposizione. Così in mancanza di aggettivi me lo sono chiesto tante volte.
Quel giorno sapevo soltanto che dovevo arrivare per tempo, raggiungere il mio gruppo, del quale non sapevo assolutamente niente. Conoscevo a mala pena chi avrebbe coordinato l’insieme e che mi aveva invitato.
Arrivai e come al solito ero in ritardo. Entrai nella stanza dove erano tutti seduti come si conviene, in tondo. Il direttore d’orchestra al centro, alla sua sinistra c’era il gruppo dei violini. A destra i violoncelli e le viole.
Dietro, l’uno accanto all’altro gli ottavini, i flauti e un corno inglese. Sullo sfondo, tra i percussionisti, trombettisti e i clarinetti c’era una sedia vuota. La mia. La sedia del fagotto.
Mi sedetti e guardai tutti negli occhi, attento a non farmi accorgere, nella discrezione forzata che contraddistingue uno timido; ma tutti erano concentrati sullo spartito. Andava benissimo così.
Mi domando sempre cosa percepisce l’orecchio di un musicista quando nell’orchestra manca un solo strumento, uno su cinquanta e non intendo certo il primo violino. Nemmeno un percussionista. Magari uno in fondo alla sala, un fagottista.
Il direttore d’orchestra, quello sì che se ne accorge, per questo chiede sempre di ascoltarci l’un l’altro, per ritrovare la nostra musica nel suono che viene da destra o da sinistra, per capire che qui l’insieme fa una sola melodia, un’anima, e che il vuoto che lascia un violino è silenzio riempito da una viola.
Il direttore d’orchestra batté due volte la bacchetta sul leggio e tutti attendemmo il segnale definitivo per incominciare il primo movimento. Il più audace di noi, che sedeva col violoncello tra le gambe, prese a suonare: era il tema principale dell’opera.
L’incipit della sinfonia dava un senso di vuoto e di indefinito. Una tecnica usata dai sinfonisti per rendere l’idea dell’ordine che nasce dal caos.
Il tema di apertura, suonato “pianissimo”, su tremolo di archi suggerì presto che da questo limbo, a volte dolce, a volte amaro, sarebbe emerso un tema poderoso che dominerà l’intero movimento. Un tema che sorge dagli abissi del nostro inconscio.
Quello che ancora oggi stiamo suonando è scritto da tempo sul nostro sparito, ed è chiaro davanti ai nostri occhi: L’Inno alla gioia, di Beethoven, l’inno alla nostra vita.
Ezio